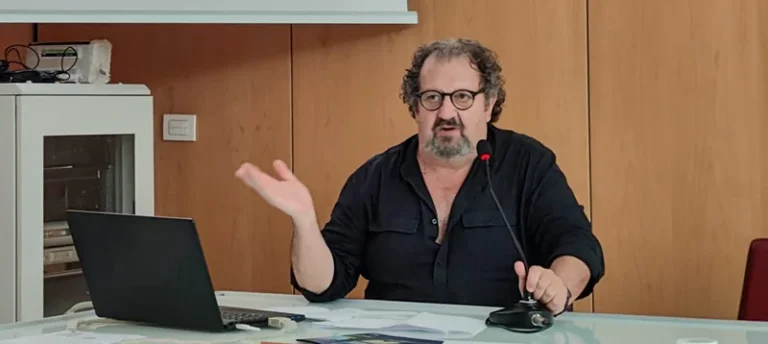Nei corsi di formazione per i giornalisti, ambito nel quale la Fondazione ENPAIA sviluppa temi, affronta problemi ed ispira soluzioni, spesso ci si confronta con il delicato equilibrio tra la profondità degli argomenti e l’esigenza di semplificare concetti complessi. L’intervista che segue ne è un esempio lampante. Giuseppe Peleggi, direttore della Ricerca e delle Rilevazioni Statistiche della Fondazione è maestro della materia perché per dieci anni è stato Direttore Generale delle Dogane e dei Monopoli di Stato. Questa intervista ci guida attraverso la storia dei dazi, offrendo spunti preziosi per distinguere il panorama economico e politico attuale, dal protezionismo di ieri da quello di oggi.
Fine della globalizzazione o almeno un forte rallentamento degli scambi internazionali; superamento del multilateralismo a vantaggio di un maggior regionalismo e di rapporti commerciali tra paesi amici. La politica daziaria di Trump prosegue lungo tale percorso?
Certamente, già da qualche anno gli avvenimenti coinvolgono e centralizzano fenomeni politicamente controversi: definizione dei settori strategici e autarchia, necessità di investimenti stranieri e utilizzo della golden share, denatalità-invecchiamento-carenza di forza lavoro attiva e accoglimento di flussi migratori, indipendenza energetica, multilateralismo o politiche regionali o dei Paesi amici, superamento del Farshoring e incentivazione del Backshoring/Reshoring o anche il Nearshoring, in sostanza si sta tentando un accorciamento delle catene globali o anche un più temerario passaggio dal libero scambio iper-globalizzato al protezionismo. Il ritorno al protezionismo, è un percorso già imboccato da qualche anno, attraverso l’introduzione di misure restrittive e di contrasto allo scambio di beni e servizi, come anche al libero fluire degli investimenti. Sono per questo aumentati i divieti, i contingentamenti, le sovvenzioni e i sostegni statali, il finanziamento di coperture assicurative, ecc., fino ovviamente all’uso dello strumento più antico, il dazio.
Nel complesso, i provvedimenti restrittivi di questo tipo alla fine del 2024 risultano triplicati rispetto al 2019 (il fenomeno è monitorato dal Global Trade Alert, che svolge una preziosa attività di puntuale rilevazione dei “colli di bottiglia al commercio internazionale”; è consultabile in: https://globaltradealert.org/activity-tracker), anche se nello specifico, sempre con riferimento al passato quinquennio, il livello medio dei dazi nel Mondo non risulta significativamente aumentato (si sono predilette in sostanza le altre misure di protezione, almeno sino all’avvento di Trump).
Il dazio è peraltro una delle tasse più antiche…
Esatto, è una delle forme impositive di più vecchia data. Il Mondo ha infatti ereditato dalle banchine del porto dell’antica Atene l’uso sistematico di un regime di tassazione sulle merci in transito, ovvero dei primi dazi che, come oggi, erano calcolati sulla quantità dei beni o anche commisurati al valore della merce stessa (gli attuali ad valorem, quindi, ndr).
Si parla di una vera e propria forma di prelievo coattivo già allora organizzata, visto che per la sua riscossione si dovevano formare specifici addetti in grado di classificare correttamente il tipo di merce, conoscerne il valore e applicare l’aliquota vigente per il transito di quel prodotto.
Anche l’antica Roma so ne fece largo uso.
Sì, i Romani copiarono dai Greci questo “pedaggio doganale”, importando anche i termini usati per i diversi tipi di dazio: portorium, publicum, vectigal, aggregando poi il tutto nella prima denominazione.
I portoria romani avevano fini puramente erariali ma con l’espansione territoriale dell’impero, e conseguentemente dei rapporti commerciali, crebbe anche l’importanza finanziaria del gettito ottenuto, per cui si determinò la necessità di creare e diffondere lungo i passaggi di confine adeguate postazioni di servizio prettamente doganale oltre che di difesa militare.
Già verso la metà del III secolo a.C. lo Stato romano, ovvero il Senato, assecondando quello spirito innovativo che da sempre ha ispirato le sue strategie organizzative per le pubbliche competenze pensò di soddisfare tale esigenza appaltando il servizio daziario. Un servizio privatizzato nella gestione per una fetta della finanza pubblica, che in tal modo era peraltro governata, tanto è vero che le aliquote daziaria, pur differenziate per le diverse province dell’Impero non erano decise dai Governatorati (e quindi dagli ex-Consoli), ma direttamente dal Senato.
Gli appaltatori, chiamati pubblicani dal termine tecnico che individuava i dazi doganali (i “publicum populi Romani”), formarono comunque un ordine temuto e potente, anche perché composto da membri provenienti dalla classe dei Cavalieri: un organismo speciale che finiva per collocarsi fra il Senato ed il popolo, disponendo peraltro anche di incarichi giurisdizionali.
È di Cicerone l’elogio della categoria dei pubblicani conosciuta come “Oratione pro Plancio”, ma in realtà non tutti i pubblicani erano meritori di elogio atteso che, una volta divenuti casta, molti di loro si impegnavano alacremente più per conseguire l’arricchimento personale che non per l’interesse erariale della Repubblica. Accuse di ruberie, corruzione, abusi e prevaricazioni segnavano la quotidianità di ogni provincia. In epoca imperiale, la capacità dei pubblicani era comunque ancora ampiamente riconosciuta, tanto che le province asiatiche ritennero di erigere un monumento marmoreo in onore di Flavio, pubblicano e padre dell’imperatore Vespasiano, proprio per l’onesto esercizio delle sue funzioni (difficile comunque capire se l’opera ebbe veramente l’intento di onorare un padre lavoratore oppure di lusingarne il figlio imperatore).
Un settore strutturato e organizzato quindi?
Esattamente. D’altra parte, considerata l’importanza del gettito ricavato, ovviamente, i Romani non esitarono a realizzare un attento sistema doganale organizzato. Per ogni Provincia venne delegato un Promagister che doveva coordinare/controllare le operazioni degli uffici territoriali sottostanti, ciascuno dei quali diretto da un impiegato che disponeva per i suoi ordini di numerosi schiavi (portitores milites), ai quali erano affidate diverse mansioni manuali connesse all’ispezione fisica delle merci, nonché dotato di una guarnigione di guardie armate (stationarii milites), ovvero la milizia incaricata di proteggere gli uffici dal brigantaggio e di intercettare/fermare i colpevoli di eventuali forme di contrabbando.
Ai confini più estremi dell’impero, come, ad esempio, lungo il Danubio, laddove il contrabbando era eseguito da gruppi di barbari in difesa armata di scorta ai portatori, per disposizioni organizzative dettate direttamente dall’imperatore Commodo, agli stationarii ed ai portitores, vennero aggiunti robusti distaccamenti militari di solida e consolidata esperienza.
Immagino che i Romani non esitarono a dedicarsi alla materia strutturando una ordinata legislazione.
Ovviamente. Le leggi fondamentali che regolavano la materia daziario-doganale sono rintracciabili nel Digesto romano (D. XXXIV, IV De publicanis, et vectigalibus, et commissis; D. XL IX, XIV De iure fisci; D. LXVII De regulis iuris, De fisco).
Tali norme costituiscono gli elementi basilari della legislazione doganale e contengono: i principi del daziamento ad valorem (octava), le norme sulle responsabilità dei pubblicani e i privilegi del fisco.
Proprio ai fini degli interessi fiscali venne introdotta e fissata la distinzione tra “crimina” (delitti pubblici) e “delicta” (delitti privati).
Un altro riferimento “brevettabile” riguarda il criterio della maggiore punibilità dell’azione dolosa in contrabbando, allorquando nella Lex Aquiliae, si stabilì che l’actio è applicata “in simplum” (solo pagamento dei diritti) contro colui che confessa e “in duplum”, contro colui che nega.
Una vivace attività normativa quindi…
Già, perfettamente in linea con la vocazione romana. Una serie di leggi di politica doganale, emanate sia in epoca repubblicana che imperiale, hanno infatti riguardato l’attività di politica fiscale manovriera dei dazi vigenti sui diversi prodotti nelle varie città e province: istituzione, modifiche, riordino e armonizzazione o soppressione, estensione territoriale, esenzioni temporanee, ecc..
Nel merito, solo rammentando le principali:
- a) nel 199 a.C., i censori Publio Cornelio Scipione e Publio Elio Peto stabilirono il portorium a Castrum, Capua e Pozzuoli;
- b) nel 179 a.C., i censori Marco Emilio Lepido e Marco Fulvio Nobiliore imposero nuovi portoria;
- c) nel 60 a.C., si ebbe la legge Cecilia, proposta dal pretore Cecilio Metello Nepote, con la quale vennero soppressi i portoria in Italia;
- d) successivamente, Cesare abolì la legge Cecilia e stabilì nuovi diritti doganali sulle merci di provenienza estera (Svetonio – Vita dei Cesari);
- e) durante il regno dell’imperatore Claudio, si limitò la riscossione dei dazi da parte delle società di pubblicani e si diede inizio alla gestione amministrativa statale diretta dei servizi doganali. Per porre fine alla gestione degli appaltatori e superare quindi la fase di privatizzazione del servizio, venne creato un corpo di funzionari erariali dipendenti dallo Stato che, ad imitazione del termine greco, vennero chiamati “telonari’’.
Deve evidenziarsi però che, comunque, per diversi secoli, non si ebbe un sistema doganale uniforme per tutti i confini dei territori/possedimenti dell’antica Roma. Ai tempi dell’Impero, le fondamentali circoscrizioni doganali erano: l’Italia, la Sicilia, la Spagna, la Gallia, la Britannia, l’Illirica, l’Asia, la Bitinia e Ponto, la Siria, l’Egitto e il Nord Africa. In ciascuna vigevano aliquote d’imposizione diverse. In Sicilia le merci venivano tassate al 5%, in Asia l’aliquota era del 2,5%, in Gallia era pure del 2,5% così come nel distretto di Bitinia e Ponto.
Rispetto ai livelli paventati dal Presidente Trump erano però relativamente bassi.
Esatto. Solo a partire dal IV secolo, si giunse ad una parificazione daziaria in tutto il territorio dell’Impero romano con un’aliquota relativamente alta, pari al 12%, che confrontato col 2,5%, la misura prevalente nei secoli precedenti, fa diventare quell’inasprimento un interessante indizio delle difficoltà finanziarie di Roma nel periodo del Basso Impero.
In sostanza, si potrebbe pensare “alti dazi in basso impero”, dove i livelli erano comunque minimi rispetto a quelli minacciati dal Presidente statunitense, ma forse è meglio chiudere con un “Sic transit gloria mundi”.
La storia, come sempre, offre preziose chiavi di lettura per il presente. L’intervista al Dott. Peleggi ci svela come i dazi non siano un’invenzione moderna, ma uno strumento fiscale risalente all’alba delle civiltà. È affascinante notare la continuità nella loro funzione e nelle dinamiche di gestione, tra pubblico e privato, efficienza e corruzione. Tuttavia, al di là delle disquisizioni storiche, è fondamentale sottolineare che, sebbene efficaci nel breve periodo per le casse statali o per proteggere determinate industrie, i dazi si sono quasi sempre rivelati una sciagura nel lungo termine. Ostacolano il libero scambio, aumentano i costi per i consumatori, rallentano l’innovazione e generano spesso ritorsioni, innescando guerre commerciali che non lasciano vincitori, ma solo economie zoppicanti. La lezione della storia, in questo caso, sembra essere chiara: la fluidità degli scambi è quasi sempre preferibile alle barriere.